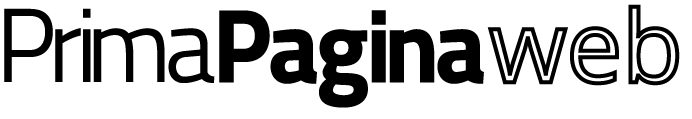Il 2 luglio scorso è mancato a New York Elie Wiesel, intellettuale premio Nobel per la Pace, reduce dai campi di Auschwitz e Buchenwald dei quali ha lasciato testimonianza ne “La Notte”: memoriale prezioso per rendere eterne le tracce dell’Olocausto, che diventano sempre più flebili con la scomparsa degli ultimi testimoni diretti.
Il 2 luglio scorso è mancato a New York Elie Wiesel, intellettuale premio Nobel per la Pace, reduce dai campi di Auschwitz e Buchenwald dei quali ha lasciato testimonianza ne “La Notte”: memoriale prezioso per rendere eterne le tracce dell’Olocausto, che diventano sempre più flebili con la scomparsa degli ultimi testimoni diretti.
La narrazione di Wiesel – urge ricordarlo – non è un evento scontato, perché dalla fine della guerra e per dieci lunghi anni egli non volle riferire riguardo alla sua esperienza, fino al tempo in cui lo scrittore cattolico François Mauriac lo persuase a rendere fruibile per un vasto pubblico il testo yiddish “E il mondo rimase in silenzio”, già completo ma rifiutato dalle case editrici, che lo giudicavano morboso e ridondante; nel presentare in seguito la versione definitiva, breve e magnifica, dal titolo “La Nuit”, il francese osservava:
“Il ragazzo che ci racconta qui la sua storia era un eletto di Dio. Non viveva dal risveglio della sua coscienza che per Lui, nutrito di Talmud, desideroso di essere iniziato alla Cabala, consacrato all’Eterno. Abbiamo mai pensato alla conseguenza di un orrore meno visibile, meno impressionante di altri abomini, ma tuttavia la peggiore di tutte per noi che possediamo la fede: la morte di Dio in quell’anima di bambino che scopre tutto a un tratto il male assoluto?”
Già, Dio: l’entità chiave che serpeggia tra le righe di ogni pagina: il grande presente e il grande assente. Ciò che separa l’opera di Wiesel da quella di Primo Levi: il Torinese scientifico, sezionatore e razionale; l’altro crudo, ma carico di simboli e intriso del misticismo nel quale era cresciuto.
Eliezer, nato a Sighet in Transilvania, apparteneva a una famiglia di Ebrei colti e osservanti; i genitori, Shlomo e Sarah Feig, stimatissimi all’interno della comunità, lo avevano iniziato agli studi linguistico-letterari e religiosi, trasmettendogli l’amore per il sapere e la spiritualità; nel 1944, all’arrivo dei Tedeschi, dopo essere stato cacciato dalla propria casa ed aver vissuto in entrambi i ghetti della città, venne deportato ad Auschwitz. La mamma e la sorella minore non sopravvissero alla selezione d’ingresso e le sorelle maggiori ricomparvero solo alla fine del conflitto; Elie rimase col padre, assieme al quale attraversò l’orrore quotidiano e la paura delle camere a gas, in una improponibile inversione di ruoli: il quindicenne che prende in carico l’adulto, progressivamente più debole e rassegnato, sperando intanto di liberarsene per sfuggire il peso e conservare la forza di lottare per sé. Il dolore al ricordo di simili sentimenti, così frequenti tra i prigionieri, perseguiterà Wiesel per il resto della sua esistenza.
Mi ha sempre colpita, tra diversi racconti della Shoah, l’efferatezza di certe immagini nel testo, in particolare quelle relative alle pubbliche impiccagioni di chi si opponeva agli scagnozzi dell’universo concentrazionario: il giovane Elie venne obbligato per due volte dalle SS a guardare i visi deformati dei condannati alla forca, e la fede nell’Altissimo e nell’umanità, già vacillanti all’arrivo in lager, svanirono attorno al cappio; il pensiero del prossimo cedette il passo all’istinto di sopravvivenza e alla sua carica di egoismo cieco.
In campo non esistevano madri, padri, fratelli e amici.
Per un tempo indefinito i prigionieri erano impegnati nella lotta di tutti contro tutti: un pezzo di pane per mezza razione di zuppa, la corona d’oro del dente in cambio di un paio di scarpe, la gamella per il cucchiaio di ferro, qualsiasi cosa pur di accedere ai favori che collocassero nella ‘zona grigia’ di cui Levi parlò nel saggio “I Sommersi e i Salvati” e che rappresentava la vita stessa contro quella del compagno, chiunque fosse. Sullo sfondo, l’incubo del fumo nero sui camini di Birkenau, a ricordare agli Ebrei che i Tedeschi non avrebbero fatto sconti neppure ai privilegiati: ‘pezzi’ utili al Reich, ma ancora per poco.
Elie Wiesel è stato narratore di spicco di questo inferno, uno dei migliori per raffinatezza di scrittura. Ha parlato ai lettori coniugando la sintesi mirabile e la crudezza della verità: il codice legittimo per raccontare l’infame abominio del ventesimo secolo, nella speranza – infondata – che la conoscenza sia magistra vitae.
La giornalista Susanna Nirenstein, in un articolo in memoriam, a giusto titolo si è interrogata: “Cosa sarà delle nostre vite senza di lui?”
Il suo ricordo sia dunque benedizione e monito per l’intera umanità.
di Simona Cascetti